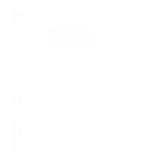Indipendentemente dalla definizione ufficiale dell’Antropocene, che prima o poi verrà adottata, la proprietà che forse più di ogni altra definisce l’epoca umana in corso è la persistenza. L’umanità brucia combustibili a base di carbonio e quello permane, si accumula nell’atmosfera e avvolge la Terra come una coperta in piena estate. Stampiamo bottiglie di plastica in poche frazioni di secondo, le utilizziamo una sola volta, e noncuranti le gettiamo: se non saranno riciclate, impiegheranno diversi secoli a decomporsi. Innalziamo nuovi edifici in calcestruzzo anche quando ci causano più danno che beneficio, liberando gas serra e producendo rifiuti edili di cui non sappiamo ancora come disporre. Più a fondo comprendiamo l’ecologia più ci accorgiamo che non esiste un «altrove» in cui nascondere le esternalità negative di quel che facciamo. Nulla sparisce per davvero: è come se gli oggetti non si esaurissero con il loro utilizzo. Rimangono qui, sulla Terra assieme a noi, in una forma inedita, e spesso problematica, da gestire. Nel lungo termine diventeranno tecnofossili. Nel breve, possiamo considerarli dei memoriali post-moderni del principio di persistenza dell’Antropocene.
Nulla sparisce per davvero: è come se gli oggetti non si esaurissero con il loro utilizzo. Rimangono qui, sulla Terra assieme a noi, in una forma inedita, e spesso problematica, da gestire.
Per capire quanto a lungo la cosiddetta tecnosfera – cioè l’enorme agglomerato di manufatti che abbiamo prodotto nel corso della storia e accumulato sulla superficie terrestre – sopravvivrà all’essere umano, dobbiamo immaginare un pianeta senza di noi, variabili indipendenti che influenzano il destino di tutto il resto. È un esperimento mentale semiserio, in cui si sono cimentate decine di studi scientifici, passati in rassegna da Alan Weisman in Il mondo senza di noi (2008) e più di recente da Telmo Pievani in La terra dopo di noi (2019). Se mai dovessimo sparire all’improvviso, la natura non impiegherebbe poi molto – qualche secolo o al più qualche millennio – a disfare le monumentali architetture antropiche. Noi umani siamo infatti degli infaticabili manutentori, e senza i nostri continui interventi anche le più solide opere edilizie andrebbero inevitabilmente in rovina. Resisterebbero qualche migliaio d’anni in più gli artefatti in ceramica, in bronzo e in ghisa, materiali particolarmente duraturi, così come gli edifici in pietra di maggiori dimensioni, ma se consideriamo un arco temporale sufficientemente lungo – la Terra avrà vita per altri 5 miliardi di anni ancora! – ogni sorta di manufatto umano precipiterà presto o tardi nell’indistinto. Tra le ultime a lasciare il pianeta, con ogni probabilità, le microplastiche in sospensione nei fondali marini e oceanici: sempre che ci riesca, ci vorrà molto tempo prima che l’evoluzione selezioni organismi viventi in grado di metabolizzarle e cancellarne ogni traccia.
Mitigazione e adattamento
Fuori dall’esercizio speculativo e dal gusto un po’ macabro di immaginare un mondo senza esseri umani, è difficile prevedere quale sarà il futuro dei monumenti al tempo del riscaldamento globale. Sappiamo però con ragionevole certezza che i cambiamenti climatici stanno già riducendo il ciclo di vita di molti materiali da costruzione, dunque del patrimonio edilizio e dell’architettura monumentale esistenti.
Nel 2020, al quattordicesimo Congresso internazionale sul deterioramento e la conservazione della roccia, sono stati presentati oltre 170 studi scientifici, 13 dei quali dedicati all’impatto del cambiamento climatico sul patrimonio edilizio e in particolare sul calcestruzzo, che rimane tuttora il principale materiale da costruzione. In sintesi: con la febbre planetaria aumentano l’intensità e la frequenza delle precipitazioni, l’umidità, la temperatura e l’inquinamento dell’aria, l’esposizione ai raggi ultravioletti della luce solare, l’acidità dell’acqua piovana e la forza dei venti – tutti agenti metereologici che hanno un effetto deleterio sulla durabilità dei materiali. A vedersela peggio saranno gli edifici e i monumenti nelle località costiere, perché lì l’effetto corrosivo e degradante degli eventi climatici si combina alla maggiore concentrazione di sale nell’aria, all’erosione delle coste e alla risalita del cuneo salino – cioè l’intrusione di acqua salata nel sottosuolo – per via dell’innalzamento del livello delle acque.
Il più delle volte mitigazione e adattamento vanno di pari passo, e non capita di rado che il problema con cui ci dobbiamo confrontare nasconda già in sé una possibile soluzione.
Quando pensiamo al futuro del patrimonio edilizio, soprattutto di quello costiero, tendiamo a contrapporre le strategie di mitigazione a quelle di adattamento climatico: investire nell’efficientamento energetico per ridurre le emissioni domestiche oppure in opere di consolidamento per la difesa degli edifici dalle conseguenze del riscaldamento globale. In verità, il più delle volte mitigazione e adattamento vanno di pari passo, e non capita di rado che il problema con cui ci dobbiamo confrontare nasconda già in sé una possibile soluzione. Prendiamo il cemento: tolti i combustibili fossili, è il materiale che genera più emissioni in assoluto. Oggi si studia per rimpiazzarlo con alternative a emissioni zero o negative e già si cerca di miscelarlo con l’anidride carbonica per intrappolarla direttamente nel calcestruzzo – pare che l’operazione renda il materiale più solido, oltre che più sostenibile. Il meccanismo si chiama “calcinazione inversa” e potrebbe fare di cemento e calcestruzzo materiali che, anziché emettere carbonio, lo sequestrano. Staremo a vedere, certo è che più passa il tempo senza che le emissioni vengano abbattute e più ci ritroveremo a dipendere da tecnologie game-changer come la calcinazione inversa per sperare di contenere il riscaldamento globale.
Nel futuro, i parchi di fonti rinnovabili potrebbero essere considerati installazioni di arte ambientale, monumenti eretti per onorare il nostro impegno collettivo nella decarbonizzazione.
Anche i parchi eolici e solari hanno il merito di combinare la mitigazione delle emissioni con l’adattamento a un clima più caldo. Questi impianti ci consentono di svincolarci, se non in toto almeno in parte, dai combustibili fossili e, se ben progettati, possono dare il meglio di sé in un mondo con sole e vento più abbondanti. Critici e scettici si ostinano ad accusare gli impianti eolici e solari di rovinare il panorama, ma, come si chiede Timothy Morton in un passo di Iperoggetti (2018) dedicato al rapporto tra estetica e cambiamenti climatici, «com’è possibile che una turbina eolica sia meno gradevole di un oleodotto?». Nel futuro, i parchi di fonti rinnovabili potrebbero essere considerati installazioni di arte ambientale, monumenti eretti per onorare il nostro impegno collettivo nella decarbonizzazione. Di più: già oggi esistono aziende che hanno ideato sistemi mini-eolici di design, installabili in contesti urbani e con pale a forma di elica del DNA, così che le macchine per produrre energia “pulita” oltre che funzionali risultino anche gradevoli da vedere in azione. From duty to beauty, si potrebbe dire senza per questo scadere nel greenwashing. L’idea di fare degli impianti eolici e solari i monumenti del futuro ha una sua poesia, una sua genialità, anche una sua utilità concreta.
LEGGI ANCHE: Earth Black Box, la scatola nera della Terra per gli umani del futuro
Monumenti per la crisi climatica
Secondo Laura Macaluso, curatrice di Monument Culture: International Perspectives on the Future of Monuments in a Changing World (2019), le nostre attitudini culturali verso i monumenti e verso la rappresentazione pubblica della memoria storica stanno cambiando rapidamente e globalmente. Viviamo nel pieno di un’ondata di ritorno dell’iconoclastia: un po’ ovunque nel mondo si abbattono statue, monumenti ed edifici pubblici perché considerati incompatibili con i valori moderni. Si demolisce il vecchio per liberare lo spazio pubblico, lo si riempie di nuovi principi e quindi si riscrive una nuova comprensione storica del patrimonio culturale. Abbattere i monumenti rappresenta da sempre l’operazione più semplice e immediata di damnatio memoriae, di distruzione creatrice e di ripristino di quel punto zero della storia da cui vorrebbe ripartire ogni utopia.
Come ogni volta, la contesa sulle opere di valore civile è una disputa non tanto sul passato in sé, ma sul fatto che la loro presenza risulta d’ostacolo alla costruzione di certi futuri desiderabili. L’elemento di novità è però rappresentato dalla crisi climatica: erigere memoriali nuovi e diversi, cambiare la concezione collettiva di cosa sia un monumento e a cosa serva, può farci capire meglio il problema del riscaldamento globale? Può aiutarci a risolverlo?
Non è una domanda da fantaecologia: se lo sono chiesti per davvero a Washington nel 2016, quando ha avuto luogo il concorso Memorials for the Future rivolto ad architetti paesaggisti. Hanno vinto Erik Jensen e Rebecca Sunter con il loro “Climate Chronograph”, il progetto di un osservatorio “vivente” che sarà gradualmente sommerso con l’innalzamento del livello delle acque. Più recentemente, nel 2019, la designer tedesca Jannis Zell ha ideato e curato l’esposizione Future Ruins. Five monuments for a human planet, un’installazione di cinque monumenti speculativi per un presente di crisi climatica e un futuro di collasso ambientale. I cinque memoriali sono: un cenotafio per commemorare l’estinzione delle api; un monolite di chicken nugget per la liberazione dei 23 miliardi di polli allevati globalmente in questo momento per l’alimentazione umana; un pozzo dei desideri per richiedere nebbia, umidità e pozzanghere quando avremo colonizzato la superficie arida di Marte; una “statua del tocco” per ricordare il nostro rapporto di assuefazione ai touchscreen; un palazzo di polistirene e altri polimeri per conservare memoria dell’era della plastica.
Erigere memoriali nuovi e diversi, cambiare la concezione collettiva di cosa sia un monumento e a cosa serva, può farci capire meglio il problema del riscaldamento globale? Può aiutarci a risolverlo?
Abbattere e tutelare
Possono sembrare pose artistiche fine a se stesse, e forse un po’ lo sono, ma un aspetto comune che caratterizza questi diversi esperimenti artistici è la progettazione di opere monumentali effimere, temporanee e destinate a passare. Nulla di persistente, nulla di cui rimarrà traccia o che concorra a rendere il problema climatico più grave di quanto già non sia.
La provvisorietà delle installazioni ci ricorda che la monumentalizzazione degli artefatti umani richiede inevitabilmente risorse economiche, impegno sociale e decisioni politiche: non tutto può essere conservato, non tutto può esserlo per sempre. Ogni anno che passa cresce la tecnosfera, il patrimonio culturale da proteggere, mentre diminuiscono le risorse a disposizione per tutelarlo. Fabio Deotto pone la questione in modo tagliente nell’ultimo capitolo del suo L’altro mondo. La vita in un pianeta che cambia (2021): col clima che si scalda e tutto il suo corollario di conseguenze catastrofiche, quale parte del patrimonio urbano, edilizio e monumentale conservare e a cosa, invece, rinunciare? Si tratta di decidere cosa difendere e cosa no, distinguere ciò che è irrinunciabile da ciò che ci basta tenere anche solo per un po’. Un giorno, forse, cominceremo davvero ad ammirare come fossero monumenti dal futuro quelle pale di metallo che roteano sul promontorio, regalandoci un’energia che non lascia impronte.