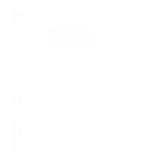«Un divieto troppo ampio sui PFAS rischia di ostacolare le ambizioni politiche dell’UE, tra cui il Green Deal e REPowerEU», afferma l’azienda chimica Chemours. «Non esistono materiali alternativi in grado di sostituire i PFAS. [Vietarli] porterebbe a una perdita di competitività e di eccellenza tecnologica», argomenta Confindustria. Non sono affermazioni isolate, ma solo alcune tra le migliaia di commenti arrivati alle autorità europee in seguito alla proposta di bandire la produzione e l’uso di PFAS nell’Unione europea. Quanto c’è di vero in queste affermazioni?
Nonostante i PFAS siano sostanze ancora poco note al grande pubblico, la contaminazione da questi inquinanti eterni è già una crisi mondiale. Rimuovere i PFAS una volta che sono stati rilasciati nell’ambiente è incredibilmente difficile (e costoso). Per questo le autorità europee stanno discutendo di metterne al bando la produzione e l’uso. All’inizio del 2023, cinque paesi europei (Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia) hanno presentato una proposta di restrizione graduale dei PFAS. La proposta, parte del regolamento europeo REACH, prevede deroghe per gli usi in cui al momento non ci sono alternative valide.
Questa proposta non è passata inosservata. Il mondo industriale europeo, a partire dai settori della plastica e della chimica, ha iniziato una vasta campagna di lobbying per difendere l’uso dei PFAS. Nel corso di un anno, con il Forever Lobbying Project, abbiamo indagato su queste attività di lobbying, raccogliendo circa 14 mila documenti inediti a partire dai commenti di aziende e associazioni di categoria alla proposta di bando e a richieste di accesso ai documenti pubblici. Con questo gruppo europeo, composto da 46 giornalisti e 18 esperti, abbiamo analizzato le strategie dei lobbisti per capire quanto ci fosse di vero negli argomenti usati per difendere i PFAS.
LEGGI ANCHE: Cosa sono i PFAS e quali rischi comportano
Cos’è uPFAS, la proposta di bando dei PFAS nell’UE
Il bando europeo dei PFAS, a cui le autorità dei cinque paesi promotori lavorano almeno dal 2019, potrebbe diventare la più ampia restrizione sulle sostanze chimiche mai approvata. “uPFAS”, questo il nome della restrizione universale dei PFAS, metterebbe al bando circa 10 mila composti, sulla base della loro «altissima persistenza» – la caratteristica a cui i PFAS devono il nome di inquinanti eterni, dovuta alla presenza in questi composti di legami carbonio-fluoro. Se uPFAS verrà approvato, la produzione e l’uso di PFAS saranno gradualmente vietati in diversi settori e in base alla presenza di alternative valide (con tempi di transizione che vanno dai 18 mesi ai 12 anni).
Secondo l’ECHA, l’agenzia europea per le sostanze chimiche, il bando è necessario a fronte del fatto che non sembra possibile usare i PFAS in modo sicuro: le emissioni nell’ambiente avvengono in tutte le fasi del loro ciclo di vita, dalla produzione allo smaltimento dei prodotti che li contengono.

Gli spray idrorepellenti a base di PFAS vengono usati per proteggere i tessuti dalla pioggia e dalle macchie. Gli spray creano una barriera che mantiene le superfici asciutte e pulite. Vengono impiegati su calzature, giacche, tende da campeggio, divani e interni auto. In passato, gli spray idrorepellenti erano formulati con PFAS a catena lunga (come C8, sostanze con otto atomi di carbonio come il PFOA/PFOS). Oggi, questi composti sono stati sostituiti dai C6, considerati PFAS a catena corta. Tuttavia, pur essendo stati inizialmente descritti come meno dannosi, i PFAS a catena corta restano parte della stessa famiglia di sostanze chimiche con gli stessi potenziali effetti negativi a lungo termine. Italia, 2025.
Una volta nell’ambiente, i PFAS sono estremamente difficili da rimuovere: secondo le stime del Forever Pollution Project, se l’Europa decidesse di bonificare spenderebbe 95 miliardi di euro in vent’anni per rimuovere dall’ambiente solo i PFAS oggi già vietati (come PFOS e PFOA) emessi in passato, assumendo che non ne vengano emessi ancora. La stima sale a più di 2000 miliardi in vent’anni per la bonifica delle emissioni attuali di PFAS, compresi i composti a catena corta e ultracorta come il TFA. Senza un bando, il progetto ha stimato che i costi per la bonifica sarebbero di 100 miliardi di euro l’anno, ogni anno, per sempre. Questa stima, basata su criteri scientifici e una metodologia elaborata in collaborazione con i maggiori esperti ed esperte del settore, è un calcolo per difetto, che non tiene conto di una varietà di costi su cui c’è ancora poca chiarezza. In Veneto stiamo assistendo a un assaggio di cosa significa cercare di bonificare: per avere acqua pulita la regione sta pagando un conto salato, come racconta un articolo su Il Bo Live.
Con il bando in vigore, l’ECHA stima che le emissioni di PFAS nell’ambiente scenderebbero del 95%.
PFAS, lobbying e disinformazione
Nel 2023, dopo la presentazione formale della proposta di restrizione da parte dell’ECHA, è partita anche la consultazione pubblica (una fase standard per questo tipo di normative europee), in cui organizzazioni e persone hanno potuto mandare i loro commenti alla restrizione. L’ECHA ha ricevuto una quantità senza precedenti di commenti e documenti, più di 5600. Nella più ampia consultazione precedente, quella sulle microplastiche, ne erano arrivati 500.
Alla consultazione hanno partecipato anche organizzazioni italiane, dalle piccole imprese alle maggiori associazioni di categoria – prime tra tutte Assogomma, parte delle federazioni di settore sotto il grande ombrello di Confindustria. Un position paper di Assogomma, che elenca una lunga serie di argomenti contro la restrizione, è citato da più di due terzi dei contributi italiani.
Oltre a questi commenti, con i colleghi e le colleghe del Forever Lobbying Project abbiamo analizzato verbali di incontri di lobbying in 16 paesi (e nelle istituzioni dell’Unione europea), scambi di email e documenti storici: quella che ne è emersa è l’immagine di una campagna di lobbying organizzata, in cui una manciata di argomenti traballanti dal punto di vista scientifico vengono ripresi e riproposti di continuo. Alcuni di questi argomenti sono fuorvianti, altri esagerati, altri del tutto falsi. Nonostante questo, stanno influenzando il dibattito politico europeo e sono entrati anche nel rapporto di Mario Draghi sulla competitività industriale del settembre 2024. Oltre ad essere una campagna di lobbying, è anche una campagna di disinformazione.

Le giacche trattate con PFAS acquisiscono proprietà idrorepellenti e antimacchia, ma il deterioramento del rivestimento può provocare la dispersione di queste sostanze nell’ambiente. Italia, 2025.
Il manuale del lobbying
Le strategie che oggi vediamo in atto per difendere i PFAS non sono nulla di nuovo. Seguono quello che viene definito il playbook, o manuale, dei lobbisti: generare dubbio, prima di tutto finanziando studi scientifici di parte, per poter affermare che non c’è consenso scientifico sui danni che derivano da queste sostanze (che siano il tabacco, i combustibili fossili, o i PFAS). E dunque alimentare un dibattito basato su false premesse, che convinca i legislatori e il pubblico che nuove norme e restrizioni non servano o siano addirittura controproducenti.
Oggi l’attenzione sui rischi della contaminazione da PFAS sta crescendo. Per questo oggi non sono in molti nel settore industriale a sentire di poter difendere a viso aperto i PFAS, allo stesso modo in cui chi ancora produce e vende petrolio sente di dover mettere in luce i propri obiettivi di decarbonizzazione (anche quando poi non li segue).
Con i PFAS, i documenti che abbiamo analizzato mostrano che la strategia è diventata quella di difenderne l’uso in settori chiave, appellandosi all’assenza di alternative. Oppure, di difendere specifiche classi di PFAS, dai rischi ancora poco chiari. In entrambi i casi, l’obiettivo è rientrare nelle deroghe e nelle esenzioni previste dal bando, o introdurne di nuove: se la strategia ha successo, la normativa ambientale viene annacquata e indebolita a sufficienza da non essere più un pericolo per l’industria.
Con l’aiuto di un gruppo dei maggiori esperti mondiali di PFAS, abbiamo vagliato gli argomenti in cui i produttori di materie plastiche chiedono una deroga per un’intera categoria di PFAS, i fluoropolimeri. Sono plastiche “ad alte prestazioni”, di cui fa parte anche il Teflon, con proprietà antiaderenti e idrorepellenti, usate in una miriade di prodotti: dalle padelle antiaderenti alle batterie al litio, dalle vernici e ai dispositivi medici.

Un lucidalabbra. I PFAS sono utilizzati in alcuni prodotti cosmetici per le loro proprietà di durata, resistenza all’acqua e capacità di fornire una finitura liscia e lucida. Quando il prodotto viene applicato sulle labbra, frequentemente bagnate o leccate, i PFAS vengono ingeriti. Italia, 2025.
Primo: mettere in dubbio la scienza
Gli argomenti delle aziende e delle associazioni di categoria riguardano prima di tutto la pericolosità dei fluoropolimeri. Nel tentativo di evitare il bando di queste sostanze, nei documenti che abbiamo analizzato si fa continuo riferimento ad affermazioni che però sono fuorvianti o false. I due studi scientifici più citati in questi documenti (complessivamente più di 800 volte) si sono rivelati essere delle ricerche finanziate dagli stessi produttori di fluoropolimeri e PFAS, tra cui aziende come Chemours, Arkema, 3M e Solvay.
Nei documenti, torna più volte l’affermazione che un bando dell’intera categoria di sostanze sia l’approccio sbagliato perché i PFAS non sono tutti uguali. «I PFAS sono come i funghi», afferma SEB (gruppo industriale francese che include Tefal, l’azienda che ha inventato le padelle antiaderenti), «ci sono quelli pericolosi e quelli non pericolosi». Che i PFAS non abbiano tutti le stesse proprietà è vero. Ma il consenso scientifico è che considerare i PFAS come un gruppo sia necessario per proteggere l’ambiente e la salute umana, perché è impensabile analizzare singolarmente ognuno delle migliaia di composti chimici in questa classe, come spiega uno studio indipendente del 2020 guidato da Ian Cousins, chimico dell’Università di Stoccolma tra i maggiori esperti mondiali di PFAS. Chiedere che i PFAS siano valutati «“composto per composto” è semplicemente una tattica dilatoria», spiega Marcos Orellana, Special Rapporteur dell’ONU sulle sostanze tossiche e i diritti umani.
Inoltre, tutte le sostanze nella classe dei PFAS condividono una caratteristica che li rende inerentemente problematici: la persistenza. I rischi derivati dalla sola persistenza, anche a prescindere da altre caratteristiche tossicologiche, sono una delle basi su cui si fonda la proposta di restrizione uPFAS. Chi si oppone al bando dei PFAS argomenta che «la persistenza da sola non indica che ci sia un rischio presente e futuro per la salute umana e l’ambiente», come afferma l’associazione di categoria Plastics Europe.
Come spiega però un altro studio guidato dal chimico Ian Cousin, le sostanze molto persistenti tendono ad accumularsi a concentrazioni sempre maggiori nell’ambiente. Nei casi in cui i rischi legati a una sostanza non sono ancora ben compresi, si dovrebbe adottare il principio di precauzione per evitare danni futuri. Ma dal momento che oggi sappiamo che i PFAS sono un problema per la salute umana, questo approccio è del tutto giustificato.

Un rotolo di filo interdentale. I PFAS vengono utilizzati in alcuni tipi di filo interdentale: i composti chimici rendono il filo più scivoloso, facilitando l’inserimento tra i denti e migliorando l’efficacia nel rimuovere la placca. Inoltre, i PFAS possono rendere il filo resistente all’umidità, evitando che si strappi durante l’uso. Alcuni produttori, consapevoli dei rischi, stanno passando a alternative più sicure per evitare l’uso di PFAS. Italia, 2025.
Secondo: generare ignoranza
Per sostenere che i fluoropolimeri sarebbero un esempio di un fungo non pericoloso, molti documenti di lobbying si appellano anche a un argomento che le nostre ricerche hanno rivelato essere del tutto falso, e potenzialmente disonesto. Secondo i loro difensori, i fluoropolimeri sarebbero troppo grandi per entrare nelle cellule (un’affermazione smentita dalla letteratura scientifica). E in più di 900 occasioni, aziende e associazioni di categoria hanno affermato che i fluoropolimeri sono “Polymers of Low Concern” secondo i criteri stabiliti dall’OCSE: sarebbero cioè dei polimeri che non destano preoccupazioni per la salute. È la stessa OCSE a smentire questa affermazione, spiegandoci di non aver mai condotto un’analisi specifica sui fluoropolimeri, e di non aver nemmeno mai finalizzato dei criteri per dire quali polimeri sarebbero “of low concern”. Anche le italiane Assogomma e Confindustria usano questo argomento falso.
Al posto di un bando, il settore industriale dei fluoropolimeri sostiene che le normative attuali siano sufficienti: le aziende si possono auto-regolare e sono in grado di limitare l’inquinamento da queste sostanze. Ma anche in questo caso, è un’affermazione su cui non abbiamo trovato un riscontro scientifico. Gli esperti evidenziano che i processi per produrre fluoropolimeri possono produrre (ed emettere nell’ambiente) anche altri tipi di PFAS: una deroga a queste sostanze, quindi, si porterebbe dietro anche altre emissioni nascoste.
Terzo: diffondere allarmismo
Mettere in dubbio lo stato delle conoscenze scientifiche sui PFAS è solo la base delle argomentazioni di questa campagna. Il vero cuore sono gli argomenti che tirano in ballo gli effetti che il bando avrebbe sull’economia europea, che vengono definiti «catastrofici» in quasi 200 occasioni nei documenti che abbiamo analizzato. Ma senza presentare studi e dati per dimostrarlo.
«Se la restrizione sarà implementata, un ampio numero di medicine importanti non sarà più disponibile», scrive il CEO della farmaceutica Novo Nordisk in un’email alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Senza una deroga illimitata per i fluoropolimeri, «l’industria automobilistica europea collasserà», si legge in un documento di Chemours, industria chimica nata come spin-off di DuPont. L’attuale proposta «eliminerà del tutto l’abilità dell’industria delle batterie di produrre celle per batterie agli ioni di litio», si legge in un contributo di Tesla all’ECHA.
Secondo l’industria dei fluoropolimeri e dei PFAS, il danno sarà così grave perché a queste sostanze «non ci sono alternative». Nella maggior parte dei documenti che abbiamo analizzato, però, questa affermazione viene fatta senza fornire prove che le alternative non ci siano (per esempio, studi che mostrino che sostanze testate come alternative non funzionano) né specificare la precise applicazioni a cui si fa riferimento, nonostante la richiesta dell’ECHA di fornire questi dati. E in due terzi dei casi in cui l’applicazione è specificata, la nostra analisi ha mostrato che in realtà le alternative ci sono.

Uno smartphone. I PFAS possono essere presenti anche nelle componenti elettroniche e nei rivestimenti protettivi di dispositivi elettronici come gli smartphone, rendendoli più resistenti all’acqua, ai graffi e allo sporco. Italia, 2025.
Il nodo delle alternative
Trovare alternative ai fluoropolimeri, e in generale ai PFAS, non è immediato. Queste sostanze sono usate così largamente proprio perché hanno qualità straordinarie che ne rendono l’uso molto flessibile, in settori diversi. Sarà impossibile, quindi, trovare sostanze che – allo stesso modo – possano essere usate nella stessa varietà di applicazioni. Ma «abbiamo lavorato molto per identificare alternative e per quasi tutti gli usi ci sono già alternative che possono essere provate e usate, o che possono essere testate» spiega Jonatan Kleimark, esperto di sostenibilità aziendale della ONG ChemSec. «Le possibilità sono molte, ma solo poche aziende [le hanno cercate] perché è più facile dire che non ci sono alternative e sperare in un’esenzione».
Una tattica comune, nei documenti che abbiamo analizzato, è chiedere di allungare i periodi di transizione per trovare alternative. La svedese Northvolt, per esempio, ha chiesto un periodo di 15-19 anni per sostituire i fluoropolimeri nelle batterie ricaricabili agli ioni di litio e la compagnia statunitense Honeywell afferma che ci vorrebbero circa 30 anni per trovare alternative per applicazioni aerospaziali. Sono richieste «esagerate» secondo Romain Figuière, ricercatore presso l’Università di Stoccolma e uno degli autori del database ZeroPM, che elenca alternative già disponibili ai PFAS in molte applicazioni. «Alcune aziende si stanno impegnando per trovare alternative, ma non capisco perché altri non vogliano fare lo sforzo di investire. Sembra che spendano i soldi per rallentare il processo invece di investire nella ricerca di alternative».
Il budget per le attività di lobbying di Plastics Europe, una delle organizzazioni che guidano questa campagna, è più che raddoppiato tra il 2020 e il 2023, passando da 2 a 5 milioni di euro. Cefic (il Consiglio Europeo delle Industrie Chimiche, un altro degli attori forti in questa campagna), dichiara di spendere più di 10 milioni di euro l’anno in attività di lobbying.

Una mantella per la pioggia. I PFAS, applicati sulla superficie del tessuto, impediscono all’acqua di penetrare, mantenendo all’asciutto chi la indossa. Molti produttori stanno cercando di adottare alternative più sicure e sostenibili, come i trattamenti idrorepellenti fluorine-free, per ridurre il rischio di contaminazione da PFAS. Italia, 2025.
Prodotti senza PFAS
In alcuni settori, come gli imballaggi alimentari e l’abbigliamento, le alternative ai PFAS si cercano (e trovano) già da tempo. La ONG ChemSec ha costruito una rete di aziende che si stanno impegnando a eliminare i PFAS dai loro prodotti. Ne fanno parte anche imprese in quelli che la campagna di lobbying pro-PFAS definisce settori chiave, che crollerebbero senza i PFAS: energie rinnovabili e tecnologie per la transizione energetica, batterie, semiconduttori.
«I PFAS sono nella maggior parte dei moduli solari standard», spiega Gerard de Leede, CTO dell’azienda nederlandese Solarge, che produce moduli solari privi di PFAS. Sono usati principalmente negli strati che proteggono le celle e il retro del pannello dagli agenti esterni, come umidità e ossigeno. Solarge invece usa materiali economici e riciclabili, come il polipropilene. De Leede è preoccupato dalle conseguenze future di usare pannelli solari che contengono PFAS. «Avremo sostanze tossiche disperse nell’ambiente tra 20 anni», commenta.
«Ho iniziato a sentire sempre più spesso preoccupazioni per i PFAS. E mi è diventato chiaro che a un certo punto sarebbero arrivate restrizioni per il loro uso», spiega invece Christopher Christuk, presidente di Transene, un’azienda statunitense che produce componenti per l’elettronica. «L’ho vista come un’opportunità per lavorare su come innovare mentre ancora c’era tempo, prima che diventasse urgente», racconta. Nei loro prodotti, i PFAS venivano usati come surfattanti, cioè come sostanze che diminuiscono la tensione superficiale. Lavorando in collaborazione con un gruppo di ricercatori dell’Università del Massachussets, hanno trovato un’alternativa che, oltre a non essere tossica, ha il vantaggio di costare circa un terzo. «Mi ha sorpreso positivamente quanto sia stato veloce ed efficace trovare un’alternativa [ai PFAS] per le nostre applicazioni», racconta Christuk. «Incoraggerei chiunque a non dire che semplicemente non si può fare. Bisogna analizzare il problema e pensare a nuovi approcci per risolverlo».

Una bottiglia di detergente. I PFAS possono essere presenti anche in alcuni detergenti per la casa usati per tessuti, tappeti e pavimenti. I PFAS possono aiutare a creare una protezione duratura contro polvere, acqua e sporco, mantenendo le superfici pulite più a lungo. Italia, 2025.
Il nuovo mercato delle alternative ai PFAS
Secondo l’Agenzia Europea dell’Ambiente, la contaminazione da PFAS ha già costi sanitari che ricadono sui conti pubblici (e dunque sulle nostre tasche) stimati tra i 52 e gli 84 miliardi di euro l’anno. Negli argomenti dei lobbisti, naturalmente, non emergono mai gli effetti positivi che il bando avrebbe per l’economia europea.
La vita delle persone che vivono in Europa non può essere appiattita sugli alti e bassi dell’economia. Ma pure se volessimo freddamente considerare le persone come lavoratori, prima che come esseri umani che hanno un diritto alla salute, vietare la produzione e l’uso di queste sostanze vorrebbe dire più persone sane, produttive, meno morti e malattie legate al lavoro (visto che i primi a rimetterci la salute, nella crisi della contaminazione da PFAS, sono spesso gli operai degli impianti di produzione).
«Dimentichiamo facilmente che quando la normativa europea REACH sulle sostanze chimiche venne proposta, Cefic – la più grande associazione di categoria dell’industria chimica – stimò che sarebbe costata al settore industriale tra i 20 e i 30 miliardi di euro», ricorda Gary Fooks, esperto di reati d’impresa all’Università di Bristol, che ha collaborato con il Forever Lobbying Project per analizzare le argomentazioni dei lobbisti. Il settore industriale tedesco si mobilitò contro una normativa che avrebbe provocato «una diminuzione del 6,4% del PIL tedesco». Naturalmente queste previsioni non si avverarono. Come riporta ChemSec, dopo l’approvazione del REACH le vendite di sostanze chimiche continuarono, con una crescita annua del 3,5%.
In questa campagna di lobbying, la protezione dell’ambiente (e il diritto alla nostra salute che ne deriva) viene contrapposta alla competitività industriale. Servono «chiarezza» ed «equilibrio» per far sì che le normative ambientali non soffochino l’industria, un argomento che sta avendo successo tra i politici europei. Ma è una falsa contrapposizione. «Ci sono enormi opportunità nel trovare nuove soluzioni che non saranno interessanti solo per l’Europa, ma globalmente», commenta Jonatan Kleimark di ChemSec. «È una grande possibilità per l’industria chimica di investire nel creare un mercato, invece di parlare solo del mercato che potenzialmente perderebbero. Penso che essere quelli che per primi trovano le alternative [ai PFAS] sarebbe un modo molto efficace di rafforzare la competitività europea».

Una mascherina usa e getta. Alcuni tipi di mascherine facciali usa e getta contengono PFAS, i quali possono entrare nell’organismo per via orale o nasale. Italia, 2025.
LEGGI ANCHE: Sul bando dei PFAS, si scontrano interesse privato e benessere pubblico
Con contributi di Stéphane Horel, Raphaëlle Aubert e Jose Miguel Calatayud.
Questo articolo fa parte del Forever Lobbying Project, un’inchiesta che è stata coordinata da Le Monde e che ha coinvolto 46 giornalisti e 29 testate da 16 paesi: RTBF (Belgio); Denik Referendum (Cechia); Investigative Reporting Denmark (Danimarca); YLE (Finlandia); Le Monde e France Télévisions (Francia); MIT Technology Review Germany, NDR, WDR e Süddeutsche Zeitung, (Germania); Reporters United (Grecia); L’Espresso, RADAR Magazine, Facta.eu, Il Bo Live e Lavialibera (Italia); Investico, De Groene Amsterdammer e Financieele Dagblad (Paesi Bassi); Klassekampen (Norvegia); Oštro (Slovenia); DATADISTA/elDiario.es (Spagna); Sveriges Radio e Dagens ETC (Svezia); SRF (Svizzera); The Black Sea (Turchia); Watershed Investigations/The Guardian (Regno Unito), in partnership con Arena for Journalism in Europe, e in collaborazione con Corporate Europe Observatory. Questa inchiesta è stata finanziata da: Pulitzer Center, Broad Reach Foundation, Journalismfund Europe e IJ4EU.