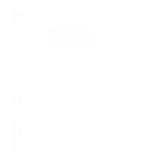«La soluzione alla prima devastante alluvione di cui si ha traccia nelle cronache, nel XIX secolo, è stata l’edificazione di tre edicole votive», spiega non senza un pizzico di ironia Jan Gemela, vicesindaco di Lichnov. Lichnov è un piccolo comune nella regione di Krnovsko, all’estremo est della Repubblica Ceca. A mitigare il rischio e proteggere la cittadina dalle devastanti alluvioni dello scorso settembre, questa volta, è stato un sistema innovativo di prevenzione basato su soluzioni naturali, che sfruttano gli ecosistemi per ridurre il rischio di inondazioni. Questi approcci prevedono l’utilizzo di “infrastrutture verdi” per mitigare gli effetti delle alluvioni: riforestare, creare aree cuscinetto dove l’acqua può essere trattenuta e defluire e rispristinare le sponde fluviali.
L’esempio di Lichnov è quasi un’eccezione, in uno stato dove la costruzione di dighe è ancora vista come la soluzione privilegiata per difendere le città dalle alluvioni. Ma l’acqua non è solo una minaccia: si può imparare a conviverci, ripensando e riqualificando gli spazi urbani, dove le piogge intense – da pericolo – possono trasformarsi in risorsa.
Repubblica Ceca, il paese in cui si costruiscono ancora le dighe
Se durante le alluvioni dello scorso settembre Lichnov ha limitato i danni è stato grazie all’impiego di nature-based solutions. Mentre i comuni vicini, come Zátor, sono stati colpiti duramente dall’esondazione del fiume Opava, a Lichnov gli impatti delle piogge sono stati minori, grazie ai bacini di contenimento creati dopo la grande alluvione del 1996. Questi bacini, che assomigliano a grandi campi erbosi, trattengono l’acqua piovana e sono affiancati da canali di drenaggio. Nonostante i risultati positivi, Lichnov rimane un caso isolato, visto che l’approccio naturale alla gestione delle alluvioni è ancora poco adottato a livello nazionale.
Un esempio emblematico di questo approccio tradizionale è la progettazione della diga di Nové Heřminovy, destinata a proteggere la regione di Bruntál dalle inondazioni. Recentemente approvato dal governo ceco, il progetto prevede la costruzione della diga entro il 2032, con un costo stimato di circa cinque miliardi di corone (circa 200 milioni di euro). Nonostante la necessità di interventi che limitino i danni causati dalle piene, ci sono dubbi sull’efficacia della diga e sui suoi impatti ecologici.
Ambientalisti e politici critici sollevano la questione delle alternative meno invasive, come il rafforzamento degli alvei fluviali o la costruzione di bacini di ritenzione più piccoli. A favore di soluzioni naturali si cita anche il minore costo di gestione che queste hanno rispetto alle grandi infrastrutture. Tuttavia, le autorità idriche e il Ministero dell’Agricoltura sostengono che senza la diga qualsiasi altra misura sarebbe insufficiente. La situazione appare paradossale: mentre la Repubblica Ceca pianifica nuove dighe, altri paesi europei, come la Spagna, stanno smantellando le loro per ridurre i costi di manutenzione.
LEGGI ANCHE: Cosa sono le assemblee cittadine per il clima, attivate a Bologna e Milano
In Spagna sono state rimosse decine di azudes
In Spagna, infatti, sono state rimosse centinaia di azudes, piccole barriere costruite lungo i fiumi per deviare il flusso d’acqua e usate principalmente per l’irrigazione agricola. Nonostante alcune polemiche e una massiccia campagna di disinformazione che associano la loro rimozione alla crescente siccità nel paese, esperti e autorità locali affermano che la rimozione delle azudes non ha avuto alcun impatto negativo sull’approvvigionamento idrico. Anzi, la capacità totale dei bacini idrici in Spagna è aumentata negli ultimi anni. Con oltre 170.000 barriere fluviali, la Spagna è uno dei paesi con il numero più alto di strutture che ostacolano il flusso naturale dei fiumi.
Queste barriere, seppur utili in passato, oggi sono obsolete e hanno effetti ecologici significativi: interrompono la continuità dei corsi d’acqua, frammentando l’ecosistema e impedendo il trasporto di sedimenti e nutrienti verso valle, con impatti negativi sulla fertilità dei terreni agricoli. La rimozione di queste strutture non solo migliora la qualità ecologica dei fiumi, ma contribuisce anche a ridurre il rischio di inondazioni causato da dighe e sbarramenti che da decenni non sono più oggetto di manutenzione.
Creare spazi anfibi: il caso di Alicante
Ma quando la piena arriva, le città possono imparare a condividere lo spazio con l’acqua e a creare nuovi ambienti: spazi che non sono semplicemente aree inutilizzabili in caso di allagamento, ma che vengono ripensati e rifunzionalizzati. In altre parole, anche quando l’acqua inonda una zona, questa non diventa uno spazio “perso”, ma continua ad avere una funzione alternativa.
Tommaso Rimondi, sociologo dell’ambiente all’Università di Bologna, spiega come in alcune città dei Paesi Bassi, tra cui Rotterdam, siano stati sviluppati luoghi urbani pensati per essere allagabili. «Non si tratta solo di avere terreni che, in caso di alluvione, diventino casse di espansione», afferma Rimondi. «L’idea è trovare soluzioni che siano contrattate e negoziate in modo che questi spazi siano utili anche quando sono sommersi. Ad esempio, alcuni parchi giochi per bambini sono progettati per essere allagabili, ma quando ciò accade, non diventano spazi inutilizzabili. Si rifunzionalizzano, diventando luoghi che rispondono a necessità diverse, mantenendo una loro utilità». Secondo Rimondi, questi spazi ibridi, che si possono definire come parte di una “città anfibia” o “città spugna”, offrono una risposta più flessibile e sostenibile alla gestione delle acque, trasformando potenziali aree di rischio in risorse utili per la comunità.

Una femmina di germano reale nel parco inondabile La Marjal nella città di Alicante, in Spagna. Fotografia di Luis Soto.
In quest’ottica, il Parco La Marjal di Alicante rappresenta una soluzione innovativa contro le inondazioni: situato in un’ex palude, il parco funge da bacino di accumulo per l’acqua in eccesso. Ha una capacità di 45.000 metri cubi ed è progettato per eventi con un tempo di ritorno di 50 anni. Nel parco sono state create aree di allagamento controllato, in cui il terreno viene pre-allagato prima dell’arrivo della piena del fiume Segura, formando un “cuscinetto” che previene la rottura degli argini e difende la città.
Ma oltre a questo, il parco è diventato un’area ricreativa e persino un habitat per la flora e la fauna locali. L’acqua raccolta durante le alluvioni viene anche utilizzata per irrigare gli spazi verdi della città. Il progetto, completato nel 2015 con un costo di 3,3 milioni di euro, ha già dimostrato la sua efficacia, proteggendo la città durante le inondazioni del 2017 e del 2019.
A questo articolo hanno contribuito Irena Buřívalová, Ainhoa Diez e Maribel Ángel-Moreno.