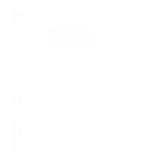Per ogni nuova culla vengono cementificati 135 metri quadrati di territorio. È una tendenza stabile, ma sempre più paradossale, quella dell’aumento del consumo di suolo in Italia. Secondo i dati ISTAT, nel 2019 sono nati appena 420 mila bambini, che non compensano i 647 mila decessi. Nello stesso anno, annuncia ISPRA, l’estensione di suolo impermeabilizzata è avanzata di altri 57 chilometri quadrati, con un ritmo di circa 2 metri quadrati al secondo.
più cemento, meno nascite
Per quanto la crisi dello scorso decennio avesse rallentato il consumo di suolo, negli ultimi anni la ripresa economica ha ridato forza al fenomeno: ogni anno una cinquantina di chilometri quadrati – pari all’estensione di un comune di media grandezza – vengono irrimediabilmente sigillati. Una volta ricoperto da asfalto o cemento, il suolo impiega tempi geologici per rigenerarsi e tornare ad essere produttivo.
Contemporaneamente, il nostro Paese ha definitivamente imboccato una parabola demografica discendente: l’Italia è un paese che invecchia – per fortuna bene – ma nel quale si fanno pochi figli. Nemmeno l’afflusso migratorio ormai è sufficiente a tenere il bilancio in attivo, alimentando le incognite sulla tenuta dei sistemi previdenziale e sanitario già dal prossimo decennio. L’incertezza del domani non ha però scalfito il consumo di suolo: in un paese in cui esistono circa 7 milioni di abitazioni poco utilizzate o del tutto disabitate, negli ultimi anni si è continuato a costruire in eccesso.

Per molti anni la crescita demografica è stata la giustificazione per costruire in eccesso. «Oggi non è più così: negli ultimi anni osserviamo un chiaro disaccoppiamento tra popolazione e consumo di suolo. In termini di incremento, il fenomeno è pressoché stabile a livello nazionale. Tuttavia, diventa variabile a scala regionale e del tutto imprevedibile a livello locale: la costruzione di un polo logistico di grandi dimensioni può rivoluzionare da un anno all’altro l’assetto comunale» chiarisce Michele Munafò, responsabile del Servizio per il sistema informativo nazionale ambientale di ISPRA che ogni anno redige il rapporto nazionale sul consumo del suolo.
La corsa a costruire
Un esempio? Il piccolo comune di Uta, nel cagliaritano, nell’ultimo aggiornamento è salito al secondo posto nazionale dopo l’ampliamento delle superfici destinate all’installazione di pannelli fotovoltaici a terra su aree precedentemente agricole (ben 58 ettari).
«Nelle Regioni in cui si prospetta l’entrata in vigore di una legge per normare il consumo di suolo, spesso si assiste a una vera e propria frenesia edilizia, nel timore che presto non si possa più costruire».
Nella frammentazione delle competenze locali – dove e quanto costruire è prerogativa del singolo comune – individuare le cause, e dunque i necessari correttivi, non è impresa semplice. «La ripresa dell’economia ha giocato un ruolo fondamentale, come dimostrano anche le diverse tempistiche con cui le Regioni hanno ripreso a costruire: quelle più produttive sono ripartite prima mentre altre hanno mantenuto un consumo di suolo più contenuto» prosegue Munafò, sottolineando tuttavia come le cause siano molteplici.
Tra queste, c’è il cosiddetto fattore “attesa della legge”. «Nelle Regioni in cui si prospetta l’entrata in vigore di una legge per normare il consumo di suolo, spesso si assiste a una vera e propria frenesia edilizia, nel timore che presto non si possa più costruire» chiarisce l’esperto.

aumenta il rischio idrogeologico e sismico
Sebbene in misura meno evidente rispetto al passato, nel 2019 il Veneto si è confermato per il terzo anno consecutivo in cima a questa poco invidiabile classifica, con 785 ettari di suolo consumato. Completano il podio la Lombardia (+642 ettari) e la Puglia (+625 ettari). Con un incremento di suolo artificiale di 108 ettari, Roma si conferma il comune con la maggiore quantità di territorio trasformato in un anno, arrivando a 500 ettari dal 2012 ad oggi. Lo spreco di suolo continua ad avanzare nelle aree a rischio idrogeologico e sismico: nel 2019 risulta ormai sigillato il 10% delle aree a pericolosità idraulica media P2 (con tempo di ritorno tra 100 e 200 anni) e quasi il 7% di quelle classificate a pericolosità elevata P3 (con tempo di ritorno tra 20 e 50 anni). La Liguria è la regione con il valore più alto di suolo impermeabilizzato in aree a pericolosità idraulica (quasi il 30%). Il cemento ricopre anche il 4% delle zone a rischio frana, il 7% di quelle a pericolosità sismica alta e oltre il 4% di quelle a pericolosità molto alta. Lungo le coste, già cementificate per quasi un quarto della loro superficie, il consumo di suolo cresce con un’intensità 2-3 volte maggiore rispetto a quello che avviene nel resto del territorio. Non mancano tuttavia i segnali positivi: la Valle d’Aosta, con solo 3 ettari di territorio impermeabilizzato nell’ultimo anno, è la prima Regione italiana vicina all’obiettivo “consumo zero” fissato dall’Unione europea; inoltre, nel 2019 si è dimezzata la quantità di suolo perso all’interno delle aree protette.