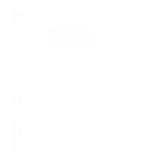Gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, i 17 SDGs che ritroviamo evocati, richiamati, sottolineati in quasi ogni singolo programma di ricerca e formazione, di investimento, di definizione di nuove politiche, di contrattazione e mediazione internazionale a diversi livelli, sono molto ambiziosi. E molto lontani dall’essere realizzati. Per tanti motivi, ma principalmente perché tendiamo a guardare a singole azioni e linee di intervento senza mettere in discussione la reale radice dei problemi, la struttura stessa del nostro modello di sviluppo, improntato ancora oggi a una visione di crescita e produttività continua. Un modello che continua ad accrescere le disuguaglianze in termini di ricchezza, di diritti, di accesso alle risorse e, in ultima analisi, di possibilità di scegliere come vivere e di farlo in modo decente per miliardi di persone.
Aggiustiamo, ritocchiamo, cerchiamo di raddrizzare la direzione. Ma raramente riusciamo ad affrontare in modo cristallino e dignitosamente coraggioso la dimensione di complessità della crisi ecologica, economica, sociale e oggi anche palesemente sanitaria che stiamo vivendo a livello globale.
Sono questi piccoli agricoltori, non le grandi corporations, che producono […] oltre l’80% del cibo consumato dai popoli della terra. E sono sempre questi piccoli agricoltori che soffrono a causa delle politiche più favorevoli al sistema dell’agribusiness.
Così, mentre spingiamo per la decarbonizzazione, continuiamo a dare incentivi per oltre 137 miliardi di euro l’anno al settore dei combustibili fossili, come una recente corposa inchiesta del collettivo Investigate Europe – Europe’s love affair with fossil fuels – ha raccontato nel corso dell’estate 2020 con una massiccia mole di analisi di dati e documenti ufficiali. E, similmente, mentre consideriamo che la produzione alimentare attuale non basta, continuiamo ad accettare che le grandi corporations agro-alimentari si fondano una con l’altra arrivando a creare quasi-monopoli di potere che rendono sempre più difficile la vita dei piccoli agricoltori di tutto il mondo e che centralizzano le chiavi della sicurezza alimentare in pochissime mani.
Eppure la FAO, pur in ritardo data la mole di studi disponibili in questo ambito, è arrivata già nel 2014 a individuare nei piccoli agricoltori, in quelli che coltivano piccoli appezzamenti di terra e che costituiscono circa mezzo miliardo di minuscole aziende familiari nel mondo, i veri produttori di cibo del pianeta. Sono questi piccoli agricoltori, non le grandi corporations, che producono e rendono disponibile oltre l’80% del cibo consumato dai popoli della terra. E sono sempre questi piccoli agricoltori che soffrono a causa delle politiche più favorevoli al sistema dell’agribusiness, organizzato sempre più come una vera e propria filiera industriale, dal campo alla tavola (from farm to fork, come si usa dire ormai in diversi contesti) passando per aziende di trasformazione, distribuzione e vendita, spesso lontane migliaia di chilometri l’una dall’altra.
Iscriviti alla Newsletter di RADAR
Potrai partecipare alla crescita del nostro magazine e riceverai contenuti extra
Produrre di più è senz’altro auspicabile, ma sprecare di meno è proprio essenziale.
C’è poi una fetta molto importante di spreco alimentare, pari a circa il 30% del cibo prodotto. Una quantità immensa, soprattutto quando consideriamo che molto di questo spreco avviene quasi subito, nella fase di produzione e trasporto, prima ancora di arrivare sul mercato. E quando consideriamo che la grande sfida del presente e del futuro immediato è quella di sfamare una popolazione mondiale di circa 9 miliardi persone entro il 2050. Per cui produrre di più è senz’altro auspicabile, ma sprecare di meno è proprio essenziale.
Non c’è una risposta unica a questo immenso problema. Intanto perché la causa non è una sola. Non risolveremo il problema della fame semplicemente applicando più tecnologia ai nostri campi. Per tanti motivi. Prima di tutto perché le conoscenze scientifiche e la tecnologia sono fondamentali, non c’è alcun dubbio, ma non risolvono da sole il problema. Se così fosse non avremmo oggi ancora quasi 2.200 bambini che muoiono di diarrea ogni giorno al mondo, quando le cure per la diarrea esistono e sono pure a basso costo e non particolarmente sofisticate. I problemi, per i piccoli agricoltori di cui sopra, sono tanti: accesso ai mercati, costo delle sementi e accesso alle stesse – visto che la quasi totalità del mercato mondiale è controllato da meno di cinque immense aziende multinazionali -, siccità e mancanza di acqua, accesso alle migliori tecniche colturali pensate e adattate agli ambienti in cui loro lavorano e vivono, e non misurate o sviluppate per le grandi estensioni agricole dei paesi occidentali.
La cosiddetta banda ultra larga, necessaria per molti di questi servizi ultra tech, è accessibile circa alla metà della popolazione italiana.
La proposta di utilizzare la cosiddetta smart agriculture, con sistemi integrati di rete che raccolgono costantemente i dati e monitorano i campi, il meteo, la situazione del suolo, lo stato di salute delle piante e via dicendo è affascinante, non c’è dubbio. Ma pone altri problemi, come ad esempio la necessità di essere ben connessi in rete. E non occorre andare in un paese del Sud del mondo per capire che questo è un problema: la cosiddetta banda ultra larga, necessaria per molti di questi servizi ultra tech, è accessibile circa alla metà della popolazione italiana. Ma sono ancora molte meno le persone e le aziende che viaggiano effettivamente vicino ai 30 Mbps, ritenuta la velocità minima per molte delle operazioni attuali. Andate poi in una zona rurale o in montagna, dove vive comunque una parte consistente della popolazione italiana (circa 9 milioni di persone stanno nei comuni interamente montani) e la connettività crolla a livelli da Internet 1.0. E non è perché gli smartphone siano diventati il modo migliore per connettersi: in migliaia di paesi di montagna, secondo diversi rilevamenti, è quasi impossibile navigare dal proprio smartphone, usare regolarmente le app, vedere un video o addirittura mandare una mail!
Ingrandirsi o essere espulsi dal mercato è stato un mantra del mondo agricolo americano fin dagli anni ‘70.
Dal 2013, per esempio, nel solo Wisconsin il debito complessivo che sta in capo ai piccoli agricoltori è salito toccando cifre record di oltre 400 miliardi di dollari. Molti piccoli agricoltori hanno dovuto cedere le loro aziende a grosse compagnie che integrano i processi e automatizzano le filiere. Situazioni analoghe si registrano in Nebraska, in Iowa, Missouri e via dicendo. A inizio anni ‘90 i piccoli e medi agricoltori americani erano la metà del totale: adesso sono meno di un quarto e in gran parte non sono più produttori indipendenti, ma integrati in processi e filiere intensive ed industriali. Ingrandirsi o essere espulsi dal mercato è stato un mantra del mondo agricolo americano fin dagli anni ‘70. Oggi però, quando la FAO non solo riconosce l’importanza dei piccoli agricoltori ma decide addirittura di dedicare a loro l’intera UN Decade of family farming inaugurata nel 2019, di questi piccoli agricoltori in molti paesi ad agricoltura cosiddetta avanzata rischia di rimanere ben poco. E quando le comunità agricole si svuotano, e abbandonano i territori, questi territori non sono più presidiati, non c’è più gestione, attenzione e cura. E le città crescono. Un modello che senz’altro pone più di un problema, soprattutto quando le periferie si fanno sconfinate.
Il problema della fame e della produzione alimentare, ma soprattutto dell’accesso al cibo, è primariamente un problema politico.
Per rimanere nell’esempio americano, passare all’agricoltura high tech non ha significato mettere più cibo o cibo migliore sulle tavole degli americani. Dal sito del Dipartimento di salute, per esempio, leggiamo che ci sono più di 23 milioni di americani, inclusi 6,5 milioni di bambini, che vivono nei cosiddetti food desert, e cioè in zone che distano più di due chilometri dal più vicino negozio di prodotti alimentari che non sia un fast food o un corner shop che offre solamente junk food, il cibo spazzatura. E non solo negli Stati centrali, eh. Anche a Washington D.C., il cuore della politica americana.
Il punto sta tutto qui, in realtà. Nel capire che il problema della fame e della produzione alimentare, ma soprattutto dell’accesso al cibo, è primariamente un problema politico. Storico, economico e politico. Ben prima che scientifico-tecnologico.
Da qualche anno è in corso un dibattito feroce su una legge di riforma che porterebbe all’esproprio senza compensazione di tutte le terre non utilizzate in termini produttivi dai bianchi, ma ancora di loro proprietà. I bianchi sudafricani possiedono oggi il 70% della terra, ma sono solo il 10% della popolazione. Girando per il paese è chiarissimo che la terra non manca e si vedono enormi distese di terra recintata, non foresta naturale ma terre agricole, che non sono utilizzate per produrre cibo ma talvolta solo per ospitare, ben distanziati tra loro, pochi animali d’allevamento. Eppure oggi, in questo paese, considerato uno dei più avanzati del continente africano, un quarto della popolazione mangia troppo poco.
C’è […] il desiderio di innovare e progredire senza perdere del tutto il controllo sulla propria vita, senza dover abbandonare la propria terra, senza dipendere esclusivamente da logiche commerciali e industriali.
Non c’è una risposta univoca al problema della fame. Non c’è una sola soluzione, tanto meno una soluzione tecno-scientifica, che possa mettere fine alla povertà. Ci sono diverse strade. Raccogliendo i materiali per diverse inchieste che abbiamo realizzato sul mondo agricolo abbiamo conosciuto nuove esperienze, reti di ricerca e collaborazione sul campo, attive in diversi paesi del mondo, che cercano delle alternative al sistema industriale. Si tratta di agricoltori e ricercatori che utilizzano sementi tradizionali, diciamo pre-industriali, sulle quali non c’è il brevetto delle multinazionali, che sono state conservate in banche pubbliche o direttamente dagli agricoltori per migliorarle in campo e dare vita a produzioni locali e a nuove filiere di corto raggio. Non si tratta di piccole comunità fricchettone e nostalgiche che desiderano ispirarsi a un ipotetico e mitologico passato dove tutto andava bene. C’è al contrario il desiderio di innovare e progredire senza perdere del tutto il controllo sulla propria vita, senza dover abbandonare la propria terra, senza dipendere esclusivamente da logiche commerciali e industriali decise a migliaia di chilometri di distanza e in centri di potere del tutto impermeabili alle esigenze e necessità dei piccoli agricoltori. Senza dover sottostare a logiche post-coloniali che ancora si ispirano all’idea di dover esportare la tecnologia, la conoscenza, i saperi come se le popolazioni del mondo non avessero alcuna competenza di relazione con il proprio ambiente di appartenenza.
Le piante coltivate portano con sé una molteplicità di storie, connessioni, rapporti genetici, esperienze climatiche e ambientali, antropiche e perfino culturali.
L’agrobiodiversità è un concetto che sta ritrovando una propria definizione, dopo essere stato centrale negli studi agronomici della prima metà del ‘900 a partire da quelli del genetista russo Nikolai Vavilov, il fondatore della prima banca di semi globale, quella di San Pietroburgo, e scopritore dei centri di origine e diversificazione delle piante coltivate, e di molti suoi contemporanei. Genetisti e agronomi, consapevoli del fatto che le piante coltivate portano con sé una molteplicità di storie, connessioni, rapporti genetici, esperienze climatiche e ambientali, antropiche e perfino culturali, hanno dato vita a questo concetto in analogia a quello della biodiversità naturale per sottolineare quanto anche le piante coltivate siano in realtà inserite e immerse in un contesto altamente complesso che ormai da oltre 10mila anni va evolvendo in maniera sistemica e altamente integrata.
E senza riconoscere questa complessità si va davvero poco lontano. Tanto che anche a livello politico, in Europa così come in diverse organizzazioni internazionali, si guarda finalmente con un certo interesse all’agroecologia e all’agrobiodiversità. In anni recenti sono stati finanziati diversi network di ricerca multiattore, dove scienziati e agricoltori lavorano insieme, per capire meglio come combinare efficacemente le esigenze alimentari con quelle di riduzione dell’impatto sul clima, quelle di prospettive economiche per le popolazioni rurali, quelle di presidio dei territori e di possibilità di diversificare le scelte alimentari e nutrizionali delle popolazioni del mondo. Una combinazione che alla fin fine richiede, prima di tutto, uno sguardo di lungo periodo, una visione politica capace di andare al di là dell’interesse economico immediato e di accettare che la diversità va coltivata, mantenuta, non semplicemente preservata in modo statico ma valorizzata, in campo e nell’intero sistema agricolo.