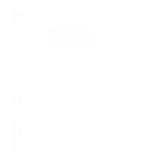Il deserto ha coordinate tutte sue, umane e narrative. Una geografia più sensoriale, una cartografia più evocativa. Per decenni, per il popolo saharawi, il deserto è stato casa. Solo che una casa, quale che sia, andrebbe sempre scelta. Per loro, invece, il deserto è stato la via di fuga dalla guerra che si è trasformata nella clessidra di pietra di una vita da rifugiati.
Il lavoro fotografico di Andrew McConnell, The last colony, che accompagna questo articolo, racconta i volti dei profughi saharawi, racconta gli spazi che abita il loro esilio, racconta quella solitudine che anche una comunità intera può provare di fronte a un mondo e a un’opinione pubblica sempre meno interessata al suo destino.

Mohammen Sheikh Salek, 30 anni, addetto al distributore di benzina. Campo profughi di Rabouni, Algeria.
«Sono nato nel campo profughi di Auserd nel 1989. Mi piaceva Auserd, ma mi sono sempre sentito un po’ un senzatetto. Era difficile vivere lì, con le tempeste di sabbia e il sole. Mi sentivo sempre come se avessi perso qualcosa. […] Questo è solo un lavoro per passare il tempo. Sono un soldato in attesa della guerra. Mi sono addestrato con il Polisario per un anno e ora sono un istruttore per i giovani saharawi nell’uso delle armi. Tutti i giovani saharawi sanno usare le armi. Rifiuto il cessate il fuoco, sta bloccando la nostra possibilità di essere liberi. Il Polisario lo accetta, ma non so perché. Credo che troveranno una soluzione. Nei prossimi incontri con il Marocco, se non troveranno una soluzione, dovremo tornare in guerra».

Djimi Elghalia, 48 anni, vicepresidente dell’Associazione saharawi delle vittime delle gravi violazioni dei diritti umani commesse dallo Stato marocchino (ASVDH). Dintorni della città di El Aaiún, nel Sahara Occidentale controllato dal Marocco (Repubblica Araba Saharawi Democratica).
«Nel 1986 mi sono trasferita a El Aaiún per lavoro dopo essermi laureata in agricoltura. L’anno successivo sono stata arrestata insieme ad altre 500 persone per aver cercato di organizzare una manifestazione per l’indipendenza prima di una grande visita delle Nazioni Unite. […] Mi interrogarono e usarono torture fisiche e psicologiche. Sono stata rilasciata nel 1991, […] grazie alle pressioni di organizzazioni internazionali come Amnesty International. Nel 2005 abbiamo fondato l’ASVDH. Le autorità marocchine impediscono all’associazione di lavorare, nonostante il tribunale ci abbia autorizzato a farlo. Lavoriamo dalle nostre case utilizzando internet e ospitiamo visitatori internazionali, ma il Marocco continua a perseguitarci e ora gli stranieri non sono autorizzati a farci visita. Siamo convinti che otterremo l’indipendenza, ma dipende dalla pressione internazionale».
La notte dei saharawi
La prima volta che ho visitato i campi profughi saharawi (dove vivono circa 170mila persone, divise in cinque campi) in Algeria, ero arrivato all’aeroporto di Tindouf. La strada fino alle tendopoli era già l’ingresso in un altrove. Quello che rammaricava i più anziani della comunità era che i giovani avevano iniziato a costruire case in muratura, rinunciando alle tende, come a dichiararsi vinti, come ad accettare che non sarebbero mai più tornati a casa.
Quello che non puoi dimenticare è il cielo, di notte, nel deserto. McConnell ha scelto proprio quella terra di mezzo della giornata nei campi profughi saharawi, tra la fine di giornate troppo calde e il momento appena prima della notte oscura, quando vecchi e bambini, uomini e donne si ritrovano a guardare il cielo stellato. Rivedere queste immagini mi ha ricordato profondamente quale sia la nostalgia dell’attesa di un futuro per un popolo intero. Oggi, dopo oltre quarant’anni di esilio, dove è casa per i saharawi?

Ali Salem Salma, 41 anni, statistico del governo saharawi, mentre guarda la TV a casa con la moglie Nabba e il figlio di quattro anni Khadda. Campo profughi di Smara, Algeria.
«Sono nato a El Aaiún nell’ottobre del 1968. Nel 1975 abbiamo costruito una casa a Zemla, un quartiere della città. Alla fine del ’75 il Marocco invase le nostre città durante la “marcia verde” e i soldati marocchini ci dissero di lasciare la nostra casa. I civili marocchini si trasferirono in tutte le case. Abbiamo trascorso sei mesi in Algeria nei campi profughi e siamo ancora qui. Abbiamo ancora la chiave della nostra casa; abbiamo anche dei documenti che dimostrano che ci appartiene. […] Molte famiglie hanno mandato i loro figli a studiare in altri Paesi, anche bambini di soli tre anni. Io ho frequentato l’università in Algeria e nel 1992 mi sono laureato in statistica e sono tornato nei campi per lavorare per il governo saharawi. So che abbiamo concordato un cessate il fuoco e le circostanze internazionali ci hanno obbligato a rispettarlo. Ma credo, e non sono l’unico, che l’unico modo per ottenere la nostra libertà sia la guerra».

Sana Zrog, 19 anni, studentessa, accanto a cisterne d’acqua nel campo profughi di El Aaiún, Algeria.
«A quindici anni ho iniziato a studiare in Libia. Tutto è gratuito: il volo, l’alloggio, i vestiti, i libri, il cibo, persino gli spazzolini da denti, lo shampoo e qualche soldo ogni mese. Ringrazio la Libia per questo, perché aiuta i saharawi. Tutti gli studenti saharawi possono andare all’università in Libia, Algeria o Cuba. […] Mi rattrista il fatto che quando tornerò dalla Libia con una laurea probabilmente non troverò lavoro. Ma la mia laurea è per il futuro. Spero di poter avere un lavoro nel mio paese quando avremo l’indipendenza. Preferisco la pace. Penso che i saharawi debbano aspettare ancora: abbiamo aspettato per trentaquattro anni e possiamo aspettare altri trentaquattro anni. Ma se le Nazioni Unite non risolvono nulla, dobbiamo combattere».
Sahara Occidentale, un territorio conteso
Il Sahara Occidentale era una colonia spagnola. Nel 1975, con il dittatore iberico Francisco Franco ormai morente, il governo di Madrid trovò un accordo – segreto – per il ritiro dal territorio che sarebbe passato sotto la gestione diretta del Marocco. Quest’ultimo, da sempre, rivendicava quel territorio come provincia meridionale della monarchia, ma solo con il ritiro della Spagna poteva concretizzare la sua ambizione. Un esercito di coloni e di civili marocchini, che servivano a coprire l’operazione militare di occupazione, passò il confine in quella che è rimasta nota come la Marcia verde.
Il popolo saharawi, indomito e fiero, abituato a una dominazione spagnola molto lasca, organizzò la difesa con le milizie del Fronte Polisario, formazione politico-militare che rappresentava i saharawi. Erano decisi a veder riconosciuto quel diritto all’autodeterminazione che valeva per il resto del mondo post-coloniale alla fine degli anni Settanta.

Mohamed Salem Ali, 18 anni, venditore d’acqua. Campo profughi di Dakhla, Algeria.
«Sono nato a Dakhla. Quando i miei genitori mi hanno detto che vivevo in un campo profughi, non riuscivo a capire. Mi sentivo triste sapendo che vivevo in un campo e che i miei genitori erano stati cacciati dal loro paese».

Azmah Laulad, 18 anni, nel campo profughi di Auserd, Algeria, con le luci di Tindouf sullo sfondo.
«Ora sto facendo mattoni e presto io e mio fratello costruiremo un negozio. Venderemo telefoni cellulari, perché qui non ci sono abbastanza negozi di telefonia. Qui è una tragedia, la gente deve tornare [nel Sahara occidentale]. Se possiamo ottenere la nostra indipendenza in modo pacifico è meglio, ma se sarà necessario dobbiamo andare in guerra. Sono privato di un lavoro, della mia libertà, di tutto. È la volontà di Dio. Se ci sarà una guerra mi arruolerò nell’esercito».
Occupazione di fatto
Ma non è andata così. Dopo una fase acuta del conflitto, la questione si è congelata: il territorio del Sahara Occidentale, da nord a sud, è diviso a metà. Da una parte, verso il mare, la zona occupata dal Marocco; dall’altra, la Repubblica Democratica Araba Saharawi (RASD), cioè lo stato dei saharawi. Nel mezzo, una barriera eretta dal Marocco, che costa una fortuna alle casse di Rabat. Tra barriera fisica e controllo con sofisticati mezzi di sorveglianza – passando per le rudimentali ma letali mine antiuomo – occupa oltre 1600 chilometri in mezzo al deserto, ma arriva a sorvegliarne oltre 2500. Dal 1991, anno del cessate il fuoco, le Nazioni Unite (tramite la missione Minurso) tentano di organizzare il referendum per l’autodeterminazione, ma il Marocco bara, spostando costantemente gli equilibri demografici.
Da allora la situazione si è cristallizzata, e il Marocco fa leva sulla più grande paura dell’Europa, i migranti, per portare l’Unione europea ad accettare ormai come dato di fatto l’occupazione. Eccola, la solitudine dei saharawi, che gli scatti di McConnell racconta così profondamente.
Vietato parlare dei saharawi
L’ultimo episodio risale allo scorso anno quando Brahim Ghali, leader politico saharawi, ha contratto il COVID-19. La Spagna, che ha compensato con la cooperazione internazionale i sensi di colpa per aver lasciato mano libera all’occupazione marocchina, ha accettato di curarlo, scatenando le ire di Rabat. Che ha risposto inondando di profughi le isole Canarie, nonché Ceuta e Melilla, exclavi spagnole sulla costa africana.
Il governo spagnolo si è spaventato, anche perché le guardie di frontiera marocchine fanno il lavoro sporco contro i migranti al posto dell’Unione europea. Così dimostrano i fatti del 24 e 25 giugno scorsi, quando almeno 37 persone sono morte nel tentativo di entrare a Melilla. Il premier socialista spagnolo, Pedro Sánchez, ringraziando in maniera surreale il Marocco, ha annunciato che la Spagna sosterrà la posizione marocchina sulla questione saharawi.
Un colpo drammatico per il popolo del deserto, che perde così anche le ultime speranze di veder riconosciuta quella autodeterminazione che sancisce il diritto internazionale. Ma perché il Marocco tiene tanto a quel territorio? Nel paese sono tre gli argomenti dei quali è vietato parlare: la monarchia, il legame di questa con l’Islam e la questione del Sahara Occidentale. Non sono solo questioni nazionalistiche ma anche, e soprattutto, questioni economiche. Il Sahara Occidentale, infatti, è una miniera d’oro per il Marocco.

Josef Mohamed Galil, 14 anni, in una vecchia piscina nel campo profughi di El Aaiún, Algeria.
«Ho imparato a nuotare in Spagna. Sono stato cinque volte nei Paesi Baschi. Ho fatto surf a Bilbao, a volte riesco anche a stare in piedi. Mi manca il mare quando torno qui. Gli spagnoli amano i Saharawi e vogliono aiutare i bambini, così andiamo lì d’estate. […] Quando avevo circa undici anni ho iniziato a capire che ero un rifugiato, era brutto e non mi piaceva. Voglio diventare un calciatore del Real Madrid. Non abbiamo una nazionale di calcio perché non siamo indipendenti, quindi tiferò per l’Algeria ai Mondiali».
Le risorse del Sahara Occidentale
Una prima risorsa chiave, alla quale il Marocco non rinuncerebbe mai, è la pesca. Ciclicamente, il governo di Rabat rinnova l’accordo di partenariato con l’Unione europea per la cessione – al prezzo di circa 30 miliardi di euro – di queste zone di pesca del suo mare. Solo che vende anche quel che non gli appartiene, come le coste del Sahara Occidentale appunto, in palese violazione dell’articolo art.73 dello statuto dell’Onu, che vieta lo sfruttamento delle risorse nei territori contesi.
Sulla lunga strada che collega El Aioun a Dakhla, le due città principali del Sahara occupato, ogni giorno transitano migliaia di camion carichi di pesce. Il settore ittico del Sahara Occidentale rappresenta 74mila posti di lavoro e il 78% del pescato marocchino totale; nella zona, genera il 17% del PIL e il 31% del totale dei posti di lavoro locali.
Un business enorme, almeno come quello dei “poli agricoli”, serre che si trovano nella zona occupata e che forniscono ogni giorno i mercati europei di pomodori e ortaggi venduti, ovviamente, con l’etichetta made in Morocco.
Tuttavia, il vero grande business è quello dei fosfati, che da solo rappresenta, secondo i dati forniti dallo stesso governo, il 6% del PIL del Marocco. Che però si guarda bene però dallo specificarne la provenienza.

Yahdih Yahdih Mohamed, 28 anni, nel campo profughi di Dakhla, Algeria.
«Per tutti i Saharawi che hanno due nomi uguali, come me, significa che tuo padre è morto prima che tu nascessi. Mio padre è stato ucciso cinque mesi prima della mia nascita in una battaglia chiamata Lwargziz. Mia madre dice che è stata una grande battaglia, in cui abbiamo catturato 300 marocchini e abbattuto due aerei. Sono molto orgoglioso che mio padre sia morto combattendo in una grande battaglia per difendere la sua famiglia e la sua terra. […] Dopo diciotto anni di cessate il fuoco e di processo di pace, se le Nazioni Unite non riescono a risolvere questo problema in modo pacifico, la soluzione migliore è tornare alla guerra. Se qualcuno venisse a casa vostra per derubarvi o per uccidervi, restereste fermi a guardarlo?».
I giacimenti di fosfati
Il fosforo è, insieme all’ossigeno, all’idrogeno, al carbonio e all’azoto, uno degli elementi essenziali per la vita: i terreni ne contengono una certa quantità, per lo più sotto forma di fosfato di calcio. Nel 1842 nacque la prima industria chimica per la produzione dei concimi fosfatici artificiali, chiamati perfosfati. Ben presto, sono sorte centinaia di fabbriche, per lo più nelle zone agricole.
Nel frattempo sono state cercate altre fonti di fosfati. Si è scoperto che ne esistevano ingenti giacimenti negli Stati Uniti (in Florida) e poi nell’Africa settentrionale, in Egitto, Tunisia e Marocco. In questi giacimenti, i fosfati si trovano sotto forma di minerali costituiti da fosfato tricalcico, adatto per la produzione di perfosfati e quindi necessario per una domanda alimentare e agricola in costante crescita globale.
Nel 2017 sono stati estratti nel mondo 260 milioni di tonnellate di rocce fosfatiche, 140 milioni delle quali nella sola Cina. A grande distanza seguono gli Stati Uniti e il Marocco, con circa 28 milioni di tonnellate ciascuno. I ricchi giacimenti di fosfati si trovano nel Sahara Occidentale: questo ha segnato il suo destino.

Senaha Sidi Omar Baba, 51 anni. Campo profughi di Auserd, Algeria.
«Sono nata a Guelta nel 1958. Quando ero piccola la terra era verde, la mia famiglia era beduina e ci spostavamo da un posto all’altro. Ci spostavamo per l’erba per nutrire i nostri animali e non dovevamo dipendere da nessuno».

Brahim Mohamed Fadin, 17 anni, tra le dune di sabbia vicino al campo profughi di Smara, Algeria.
«Frequento la scuola superiore in Algeria e i saharawi hanno sempre i voti migliori. Stiamo imparando per il nostro popolo, impariamo a diffondere la nostra storia e in Algeria possiamo farlo. Sto studiando matematica e il mio obiettivo è diventare ingegnere. Vorrei poter aiutare il mio Paese, che ha bisogno di molti specialisti. […] Non mi piace la guerra nel Sahara, perché tutti sanno che il Sahara è un luogo pacifico e voglio che i saharawi e i marocchini vivano in pace come fanno l’Algeria e la Mauritania, come amici. Se otterremo l’indipendenza, saremo uno dei migliori Stati del mondo perché siamo conosciuti per la nostra solidarietà, amicizia e ospitalità. La vita ci ha insegnato molto, a causa di tutte le sofferenze che abbiamo vissuto».
Un’industria (statale) fiorente
Lo sfruttamento delle risorse naturali continua, nonostante sia la Corte di giustizia dell’Unione europea (per ben quattro volte) sia il responsabile legale delle Nazioni unite si siano espressi in maniera contraria. Hanno infatti ritenuto nullo, su quei territori, anche l’accordo commerciale tra Unione europea e Marocco. Nonostante la sentenza e l’attività di molte organizzazioni non governative che tentano di persuadere le aziende – con qualche sporadico successo – a boicottare i fosfati venduti dal Marocco, l’industria nazionale del fosfato è fiorente. Le attività si concentrano nell’area di Bou Craa, sotto il controllo di due industrie statali: Chérifien des Phosphates (OCP) e Phosphates de Boucraa (Phosboucraa).
Un grande nastro trasportatore, lungo 97 chilometri, trasporta quasi 2 milioni di tonnellate di fosfati all’anno dai depositi di Bou Craa al porto di Boujdour. Qui vengono lavati, essiccati e asciugati e poi spediti per essere caricati a El Aaiun. Secondo i dati dell’Environmental Justice Atlas, il reddito di tutti i fosfati venduti dal Marocco è stimato a 1,7 miliardi di dollari all’anno; OCP è il secondo produttore più grande e il primo esportatore di fosfato nel mondo.
Sulla base dei numeri del 2014, non avendo dati ufficiali più recenti, Phosboucraa nel Sahara Occidentale produce il 10% del fosfato totale e ha l’intenzione di raddoppiare la sua produzione entro il 2023.
I saharawi possono almeno lavorare in questo settore? Solo se sono immacolati dal punto di vista politico, che significa non aver mai protestato contro l’occupazione e non avere parenti tra le centinaia di prigionieri politici saharawi nelle carceri marocchine. Se sussistono queste due condizioni, possono ambire a un salario mensile di circa 150 euro, senza alcuna condizione di sicurezza sul lavoro e di previdenza.

Mariam Zaide Amar, 24 anni, sminatrice, nella foto a Mehaires, nel Sahara occidentale controllato dal Polisario (Repubblica Democratica Araba Saharawi).
«Ho sentito alla Radio Nazionale Saharawi un annuncio in cui si diceva che Landmine Action aveva bisogno di donne per lo sminamento. Ho pensato che sarebbe stato un ottimo modo per aiutare il mio popolo. Sono andata al colloquio e c’erano molte ragazze. Quando mi hanno detto che avevo ottenuto il lavoro mi sono sentita molto fortunata. Indossiamo abiti speciali e usiamo i metal detector. Quando trovo una mina la segnalo, ci metto intorno del tritolo e attacco il detonatore, poi mi sposto indietro di 300 metri con un cavo e la faccio esplodere. Quando sento di persone uccise dalle mine sto male. Ora stiamo lavorando a Mehaires, nel territorio liberato, dove ci sono molti ordigni: al momento stiamo bonificando munizioni a grappolo, ma ci sono anche granate, missili, mine anticarro e mine antipersona. Ci vorrà molto tempo per bonificare tutto il territorio, forse trent’anni. Il problema è che non possiamo lavorare a meno di cinque chilometri dal muro. Ci sono molte mine e, secondo l’accordo di cessate il fuoco, non possiamo entrare in quell’area. I marocchini hanno minato l’intera area e vi mettono delle mine ancora oggi».
Sulle spalle del popolo saharawi
In compenso, i saharawi che non hanno scelto la via della fuga durante il conflitto ne pagano le conseguenze ambientali. Quella dei fosfati, infatti, è un’estrazione che ha un grande impatto ambientale: degradazione del paesaggio, erosione del terreno, deforestazione, impatti sul sistema idrogeologico con contaminazione dei suoli, delle acque di superficie e peggioramento della qualità delle acque di falda.
Ma per il Marocco questo non conta: la capacità di produzione di fosfati nel Sahara Occidentale viene stimata in 2,6 milioni di tonnellate all’anno e le riserve di Bou Craa in 500 milioni di tonnellate. Una miniera d’oro, anche perché la qualità eccezionalmente alta del minerale di fosfato del Sahara Occidentale lo rende una merce molto ambita dai produttori di fertilizzanti. Riguardate adesso le foto di McDonnell, con gli occhi della geopoetica e non della geopolitica delle risorse. Quelle persone, con il loro cielo di stelle, vi racconteranno con il loro dignitoso silenzio di quanto siano molto più vicine a noi e alle nostre economie.

Le fotografie di Andrew McConnell sul popolo dimenticato dei saharawi del Sahara Occidentale hanno vinto il primo premio nella sezione Ritratti dei World Press Photo Awards nel 2011.